In un libro di Alberto Stabile, storia e storie del conflitto mediorientale
Beatrice Agnello
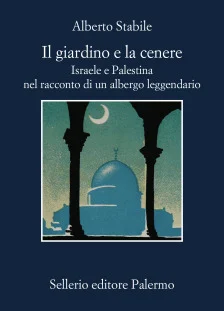
“Il Cortile delle Mogli, come veniva chiamato, era un luogo fuori dal tempo con i tavolini ricoperti di mattonelle di ceramica armena (…) vasi di fiori e alberi di ulivo e di agrumi innestati fra di loro i cui rami dispensavano ombra ora su un lato, ora sull’altro del giardino, come dettava il cammino del sole. In quello spazio quasi scavato nel corpo dell’edificio, anche il Khamsin, il vento potente proveniente dalla penisola arabica che, di tanto in tanto, investe, caldissimo, Gerusalemme s’arrestava ammansito”.
Siamo al Colony “un paradiso fragrante di lavanda, garofani e gelsomini”, un tempo residenza di una delle più importanti famiglie palestinesi, trasformato nell’hotel più affascinante del Medio Oriente, un’isola in mezzo alla tempesta di un luogo dove “il conflitto è tutto. È il motore della Storia. È il genius loci che puntualmente si rivela. È l’orizzonte di tutti i destini che si agitano sulla scena”.
Alberto Stabile arriva lì da inviato di Repubblica nel 1988, in piena Intifada. “Già nelle ore della prima colazione, la lobby (…) pullulava di giornalisti in procinto di partire a caccia di notizie. Chi incontrava per la prima volta il fixer, o l’interprete d’arabo, chi cercava un tassista di cui fidarsi, chi chiedeva una macchina a noleggio, chi arrivava giusto in quel momento chissà da dove con gli aerei del mattino e si guardava intorno stupito di ritrovarsi in quell’ambiente così raffinato e al tempo stesso così vero, come la lobby, un salone dall’antico pavimento di pietra rosa di Gerusalemme simile ad una casa delle Mille e una Notte, trasformato in caotica e poliglotta newsroom.”
E la sera “Il bar di Ibrahim era invaso di giornalisti vocianti che si raccontavano l’un l’altro le storie raccolte quel giorno, il bicchiere di birra in una mano, la sigaretta nell’altra. (…) Il bancone ricoperto di marmo chiaro, dietro al quale, Ibrahim, palestinese di pelle scura e di tratti egizi, faceva danzare le grandi mani sfiorando le bottiglie luccicanti allineate sugli scaffali di vetro alle sue spalle, era assediato dagli habitué del locale”, non solo giornalisti ma anche “attempati gentiluomini palestinesi, molto curati nei loro abiti di sartoria”, che “pasteggiavano, ogni sera, a whisky delle migliori marche”.
Ma la cifra cosmopolita e garbata dell’hotel deriva prima di tutto da quei palestinesi che vi lavorano: “La gentilezza, la disponibilità non nascevano dalle regole impartite da una scuola alberghiera e mandate a memoria ma dall’innata inclinazione dei palestinesi all’accoglienza”.
Prima di tutti George, il portiere tuttofare, che “sembrava strappato dalla foto di gruppo di una famiglia borghese di epoca ottomana, (…) l’avanguardia, il biglietto da visita di quel clima di gentilezza, di cordialità e di amicizia in cui il Colony avrebbe subito avvolto il visitatore, ancor più se straniero”.
Accanto all’hotel, una libreria e una bottega. Personaggi memorabili i proprietari, anch’essi palestinesi, il libraio Munther – che ospita scrittori come Amos Oz, David Grossman, Ian McEwan e intellettuali come Ilan Pappè, e non ascolta nenie arabe ma Mozart e Beethoven – e l’antiquario Munir – che da giovane si è giocato tutto quel che ha ereditato dal padre alla borsa di Tel Aviv – brillante narratore delle storie di oggetti e tappeti preziosi.
L’altra faccia di questa realtà è che gli amabili palestinesi che ruotano attorno al Colony devono continuamente rinnovare permessi burocratici e superare posti di blocco e sbarramenti per arrivare all’hotel e presentarsi agli ospiti puntuali con impeccabile aplomb e affabili sorrisi. I loro diritti sono ben lontani da quelli degli abitanti non arabi della città e dei dintorni, al punto che, durante la prima guerra del Golfo (1990-91), quando era atteso un attacco con armi chimiche da parte dell’Iraq, “il governo di Shamir fece distribuire milioni di maschere antigas e kit per la sopravvivenza alla popolazione israeliana. Ma nulla diede ai palestinesi dei Territori, nonostante, in base al diritto internazionale, il paese occupante fosse obbligato a garantire la salute della popolazione civile”.
Dice Stabile: “In quei giorni feci il mio primo incontro con la violenza che covava nell’animo dei civili palestinesi nel sentirsi discriminati rispetto agli israeliani anche in una situazione di emergenza come la guerra incombente”.
Fuori, Gerusalemme, sacra per tutte e tre le grandi religioni monoteiste, con la “Città Vecchia racchiusa dalle antiche mura fatte costruire da Solimano il Magnifico”, “i suoi tetti a cupola e suoi svettanti minareti, in uno scrigno di pietra. Pietra animata, si direbbe, capace di tingersi d’oro e d’arancio sotto i raggi del sole al tramonto, o di ombre metalliche sotto la luce brillante della luna”.
Lì, nella Spianata delle moschee e nei suoi dintorni, le tre fedi, ognuna con la sua certezza di verità, si contendono il richiamo alla preghiera del mezzogiorno: suonano le campane del Santo Sepolcro, si diffondono nell’aria gli appelli del muezzin della moschea Al Aqsa e le lamentazioni degli haredim davanti al Muro del Pianto.
Gli haredim, ebrei ultra ortodossi animati da implacabile odio per i palestinesi, sono anche diffidenti e ostili nei confronti di qualunque estraneo: nel loro quartiere di Mea Sharim, non gradiscono neppure la presenza di stranieri occidentali, soprattutto quando celebrano il sabato. Osservano una rigida separazione fra uomini e donne nella preghiera, non meno degli islamici, che riservano alle donne il Duomo della Roccia ricoperto di maioliche azzurre sotto la cupola dorata, poco lontano. Gli haredim sono oggi la maggioranza della popolazione ebraica di Gerusalemme.
Fra queste dimensioni si muovono quelli che Stabile – corrispondente dal Medio Oriente per lunghi anni – chiama Jerusalem boys and girls, giornalisti e fotografi americani, inglesi, francesi, tedeschi, italiani, spagnoli, giapponesi. Se il lavoro li chiama fuori dalla città, importantissimi sono gli autisti che riescono a trovare, la cui perizia, audacia, conoscenza di strade e scorciatoie, può farti arrivare per primo sul luogo di un avvenimento, evitare blocchi stradali, a volte persino salvarti la vita. Anche gli autisti sono singolari personaggi palestinesi, che per portare a casa i soldi necessari a campare si muovono fra le mille difficoltà burocratiche e poliziesche dell’occupazione israeliana e i pericoli della violenza in agguato.
Quasi un romanzo, “Il giardino e la cenere”, e il quasi si riferisce al fatto che vicende e persone sono reali e le ricostruzioni storiche e politiche molto accurate. Ma del romanzo c’è l’andamento; una città e un hotel vocati all’avventura romanzesca; personaggi che mutano nel conflitto; lo sguardo autoriale sensibile al fattore umano (e il riferimento a Graham Greene non è casuale); il tono di voce personale spesso di contenuta malinconia; una scrittura piena di immagini evocative. Fra i Jerusalem boys “alimentati dalla fame di emozioni, in un luogo che sembrava essere stato creato proprio per suscitare emozioni, alcune estemporanee e fugaci, altre rese durature dal desiderio di perpetuare anche altrove quell’atmosfera di perenne eccitazione, sbocciarono amori quasi sempre destinati a dimostrarsi effimeri e sorsero amicizie che, dopo quasi mezzo secolo, durano ancora”. Alcuni non ci sono più, bruciati dalle loro vite pericolose, come Juan Carlos Gumucio e Marie Colvin, giornalisti leggendari che sembrano usciti dalle pagine di Ernest Hemingway e Malcolm Lowry, ma sono invece reali e l’autore ricostruisce l’amore che li ha legati attraverso la sua conoscenza diretta di amico personale.
Per sé, Alberto Stabile nella narrazione riserva un ruolo di testimone e coprotagonista non invadente, ma emozionalmente coinvolto, che affina la professionalità, l’esperienza e lo spirito nel corso dei molti anni passati in Medio Oriente.
Alla fine mi sono chiesta, al di là dell’abbandono a un racconto affascinante che esubera di vita e di morte, qual è il di più che questo libro porta alla nostra comprensione del conflitto attuale, un di più che ho avvertito distintamente nella lettura. Mi sono risposta: qui non vediamo solo masse di palestinesi esasperati dall’ingiustizia e abbrutiti dalle bombe che sterminano insieme terroristi feroci, poveri cristi, agricoltori vessati e scacciati contro ogni risoluzione dell’Onu dalle loro terre, una tragedia collettiva che tocca e indigna, ma è anonima se non la vediamo incarnata nei singoli con la loro consistenza umana e la loro complessità. Qui incontriamo individui nella loro unicità, come i palestinesi del Colony, diversi uno dall’altro, tanti di personalità aperta, cosmopolita ben più degli ebrei ultraortodossi, e però soggetti a una perpetua discriminazione, compresa la negazione delle maschere antigas e poi delle mascherine anticovid fornite al resto della popolazione. Singoli travolti dalla Storia. Questo libro restituisce loro dignità personale e voce, ce li rende familiari come solo chi li ha visti da vicino può fare.
Se “Il conflitto, dunque, è l’essenza non dichiarata di questo libro”, sono le storie di protagonisti e comprimari colti in quella situazione estrema che ne rivela la natura e ne trasforma la vita a dare anima alle pagine, come in un romanzo, appunto.
Alberto Stabile, IL GIARDINO E LA CENERE Israele e Palestina nel racconto di un albergo leggendario, Sellerio 2024, €15

Scrivi un commento